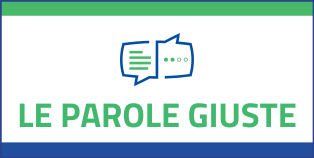FNA: 400 MILIONI PER IL 2015
Nel pomeriggio (del 4.11.14) il Ministro del Lavoro Poletti ha incontrato i rappresentanti di FISH* e FAND per affrontare il tema del Fondo non autosufficienze 2015. Come noto, il FNA, nel disegno di legge di stabilità, subisce un taglio di 100 milioni, scendendo alla dotazione di 250.
Durante l’incontro, il Ministro Poletti, sentita anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rassicurato le federazioni che la dotazione 2015 arriverà a 400 milioni. Contestualmente il Comitato 16 novembre ha incontrato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio ottenendo analoga rassicurazione.
L’incontro ha rappresentato per FISH anche l’occasione per attirare l’attenzione sul limitato finanziamento del Fondo nazionale politiche sociali e del Fondo per l’occupazione delle persone con disabilità. Quest’ultimo è azzerato per il 2015. Poletti su tali aspetti ha espresso la massima attenzione da parte del Governo, auspicando che nel corso della discussione della legge di stabilità quei fondi possano essere maggiormente finanziati.
Poletti ha richiamato pure la centralità di momenti di programmazione delle politiche sociali per la disabilità anche avvalendosi dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
“Oggi le interlocuzioni mantenute nel corso degli anni da parte della FISH hanno restituito un risultato positivo. Non possiamo comunque non ringraziare il Comitato 16 novembre per la sua iniziativa utile al raggiungimento di questo traguardo. Ora dovremo prestare attenzione alla redazione del decreto di riparto del FNA stesso che verosimilmente verrà già delineato nelle prossime settimane. Oltre a ciò prosegue il lavoro di FISH sui tanti aspetti che riguardano la qualità della vita delle persone con disabilità.”, ha dichiarato Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.
*Cui Anffas Onlus aderisce
Per approfondire
Leggi il comunicato stampa del Forum Terzo Settore
Leggi la news “Disabilità, tre manifestazioni in quattro giorni”
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA: BENE L’IMPEGNO ASSUNTO DAL GOVERNO, MA CI ASPETTIAMO ULTERIORI RISPOSTE
Arriva in questi minuti (4.11.14, n.d.r.) un comunicato stampa di Palazzo Chigi che assicura che lo stanziamento per il Fondo per le non autosufficienze verrà incrementato fino a 400 milioni, un’azione sostenuta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti che oggi (4.11.14, n.d.r.), rispettivamente, hanno ricevuto il “Comitato 16 novembre” e le Federazioni Fish e Fand, mobilitate contro i tagli al Fondo per la non autosufficienza.
“Prendiamo atto di questo impegno del Governo sulle politiche per la disabilità, – dichiara il Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore*, Pietro Barbieri – anche se spiace constatare che arriva dopo l’ennesima manifestazione di protesta, come è avvenuto troppe volte in questi anni”.
Era un anno fa infatti quando abbiamo assistito a manifestazioni in cui i malati gravi di Sla e le persone con disabilità chiedevano rispetto dei loro diritti e risorse adeguate per coprire almeno i bisogni essenziali.
“Saremo accanto alle Federazioni e ai malati per vigilare che l’impegno assunto oggi venga mantenuto. E auspichiamo che arrivino presto risposte adeguate anche in merito agli altri temi che abbiamo già segnalato, al Governo, costituire gravi mancanze nella Legge di Stabilità: dalla insufficienza delle misure di contrasto alla povertà, dei fondi per l’infanzia e l’adolescenza e degli altri fondi per le politiche sociali, al tema dell’aumento delle tassazioni per le Fondazioni di origine bancaria fino al taglio dei contributi per i patronati.”
*Cui Anffas Onlus aderisce
Per approfondire
Leggi il comunicato stampa di Fish
Leggi la news “Disabilità, tre manifestazioni in quattro giorni”
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA, SPARISCE IL TAGLIO
Fonte www.redattoresociale.it – Il taglio di cento milioni al Fondo per la non autosufficienza sarà eliminato e per l’anno 2015 le risorse del Fondo non solo saranno riportate a quota 350 milioni ma arriveranno a 400 milioni, 50 in più rispetto alla cifra stanziata lo scorso anno.
L’impegno è del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio, che ha ricevuto a Palazzo Chigi una delegazione del Comitato 16 Novembre, impegnato fin dalla prima mattina in un presidio di protesta davanti al ministero dell’Economia, in via XX Settembre a Roma. Un presidio che in primo momento era continuato anche dopo l’incontro – che si era concluso con l’impegno del governo a riportarlo a 350 milioni – e che poi nel pomeriggio è stato definitivamente sciolto dopo l’ulteriore comunicazione di Delrio che ha concesso la disponibilità di ulteriori 50 milioni.
Contemporaneamente all’incontro Delrio – Comitato 16 novembre, le due principali federazioni delle persone con disabilità, la Fand e la Fish*, sono state ricevute al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da Giuliano Poletti. Un colloquio che si è prolungato per circa due ore – molto di più della mezzora del colloquio di Delrio – e nel corso del quale anche dal titolare del dicastero del Welfare era arrivata in un primo tempo solo la rassicurazione di riportare il Fondo a quota 350 milioni. Cifra che non aveva soddisfatto le due federazioni, che avevano subito chiesto un ulteriore sforzo, così che fosse concesso un effettivo aumento del Fondo rispetto alla cifra stanziata lo scorso anno. Richiesta che è stata accolta subito dopo l’incontro e che è stata poi comunicata agli esponenti delle varie associazioni coinvolte.
*Cui Anffas Onlus aderisce
Per leggere l’articolo integrale clicca qui
Per approfondire
Leggi il comunicato stampa sull’argomento di Fish e Forum
DISABILITÀ, TRE MANIFESTAZIONI IN QUATTRO GIORNI
Fonte www.superabile.it – Il mese di novembre si apre con una settimana “calda” per la disabilità: tre manifestazioni in tre giorni, a Roma, promosse da diverse associazioni. E, in più, altre associazioni sedute al tavolo con il ministro Poletti, per discutere e provare a raggiungere un accordo sul tema critico del Fondo non autosufficienza.
Si inizia con il doppio appuntamento in piazza e nel palazzo: in presidio, sotto il ministero delle Finanze, ci sarà il Comitato 16 Novembre, a rivendicare un miliardo di euro da destinare al fondo e, soprattutto, un Piano nazionale per la non autosufficienza, finalizzato alla domiciliarità. Il comitato ha declinato l’invito del ministro del Lavoro Poletti, che ha convocato le associazioni, per il primo pomeriggio, proprio sulla questione del Fondo per la non autosufficienza. Invito accolto, invece, dalle associazioni Fish e Fand, che pure, nei giorni passati, hanno lanciato l’allarme per l’ulteriore taglio previsto dalla legge di stabilità, minacciando una mobilitazione qualora le loro richieste non fossero accolte.
Il 5 novembre, sarà invece la volta di Tutti a scuola, l’associazione di genitori di alunni disabili capitanata da Toni Nocchetti, che si dà appuntamento in piazza Montecitorio “per costringere una politica muta, sorda e cieca a occuparsi dei disabili” e per consegnare al governo le lettere dei genitori. Tante le carenze denunciate dall’associazione, in ambito di inclusione scolastica: insufficienza del sostegno, inadeguatezza delle strutture, mancanza di continuità didattica.
Appena tre giorni dopo, l’8 novembre, di nuovo la disabilità scenderà in piazza, questa volta con la “Via crucis dei malati rari”, da piazzale Numa Pompilio a piazza Castellani: una marcia “laica e pacifica in sette tappe”, promossa dal Movimento italiano malati rari, per denunciare le carenze e le criticità del Piano nazionale, approvato il 16 ottobre scorso dalla Conferenza Stato-Regioni. “Il nuovo piano è infatti ricchissimo di buone intenzioni – spiega il presidente del Mir, Claudio Buttarelli – ma completamente privo di impegni ‘definiti’ sia nei tempi di realizzazione che di individuazione di risorse da allocare per il raggiungimento degli obiettivi”.
Per leggere l’articoo integrale clicca qui
ABOLIZIONE DELLE PROVINCE E ALUNNI CON DISABILITÀ
Fonte www.superando.it – La Legge 56/07 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), la cosiddetta “Legge Delrio”, ha notevolmente modificato l’assetto istituzionale, in particolare rispetto alle Province, e, nella fattispecie, riguardo alle loro competenze relative ai servizi per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. A decorrere dal 1° gennaio 2015, infatti, le Province di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino e Venezia, più Roma Capitale con disciplina speciale, diverranno Città Metropolitane, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi alle relative Province (articolo 1, comma 16). Ad esse spetterà tra l’altro l’attuazione dell’edilizia scolastica (articolo 1, comma 85, lettera e), nonché le altre competenze che verranno concordate tra Stato e Regioni per tutte le nuove Province (articolo 1 commi, 44 e 89).
Sempre alle Città Metropolitane, inoltre, spetteranno i patrimoni delle Province cui succederanno, e anche per le nuove Province – dette “di area vasta” – si avrà un’attribuzione di competenze sulla base di un’Intesa Stato-Regioni cui seguirà una ripartizione di competenze tra Stato e singole Regioni (articolo 1, comma 91). Infine, sempre sulla base di un’Intesa Stato-Regioni, lo Stato provvederà con propri decreti all’assegnazione dei patrimoni e delle risorse alle nuove Province (articolo 1, comma 92).
Fino a quando, dunque, il nuovo assetto non avrà trovato piena attuazione, stante il principio della successione delle Città Metropolitane e delle Province “di area vasta” in tutti i rapporti attivi e passivi delle precedenti Province, i diritti degli alunni con disabilità dovrebbero avere certezza di soggetti tenuti a soddisfarli.
Una volta realizzata la ripartizione delle competenze, però , bisognerà vedere se e quale ente (nuove Città Metropolitane e nuove Province o Unioni di Comuni) dovrà erogare i servizi di trasporto gratuito, di assistenza per l’autonomia e la comunicazione e l’’eliminazione delle barriere architettoniche e sensopercettive per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, nonché per gli alunni con disabilità sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado. E questa è una partita ancora tutta da giocare nel confronto tra Stato e Regioni e nell’àmbito di ogni singola Regione. In realtà, a garanzia dei diritti degli alunni con disabilità dovrebbe giocare un ruolo notevole la Giurisprudenza che ha fornito numerosi chiarimenti in questi ultimi anni. Questo almeno nella fase iniziale di attuazione della nuova normativa, per la cui interpretazione sicuramente insorgeranno conflitti di competenze, dal taglio per lo più “negativo”, in quanto la gestione e l’erogazione di servizi comportano spese; difficilmente, infatti, vi saranno controversie circa conflitti “positivi “ di competenze, cercando ciascun ente di declinare i servizi conseguenti nei confronti degli altri.
Suppongo pertanto che arriveranno vari contenziosi – fatto che ormai si era riusciti a sanare – mentre forse il ricorso agli accordi di programma potrebbe evitare conflitti i cui effetti produrrebbero ritardi nella soddisfazione dei diritti degli alunni con disabilità e comunque una grande incertezza sugli stessi, circa i titolari degli obblighi di erogazione. Già quest’anno, del resto, si sono avute gravi lagnanze per l’assenza o le carenze nei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, da Napoli e dalla Sicilia, fino alla Lombardia. Se quindi lo Stato e le Regioni non provvederanno immediatamente a ridisegnare la ripartizione di competenze amministrative su questa materia, con il prossimo anno scolastico potremmo assistere a un pesante caos amministrativo, con gravissimi danni per gli alunni con disabilità e per le loro famiglie. Quando poi verrà definitivamente approvato il nuovo Titolo V della Costituzione, abolendo del tutto le Province, senza riassegnare immediatamente le attuali competenze amministrative, il caos rischierà di divenire insostenibile.
Si chiede quindi allo Stato e alle Regioni (tranne il Lazio), abbastanza distratte su questo argomento, di recuperare il tempo perduto e provvedere immediatamente con chiarezza. Ci si augura inoltre di non dover assistere a una vera e propria “alluvione di denunce” per «interruzione di pubblico servizio» a causa delle mancate risposte ai diritti incomprimibili degli alunni con disabilità, sanciti dalla legislazione e confermati più volte dalla Corte Costituzionale.
*Già vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).
ACCESSO ALL’INFORMAZIONE: ESPOSTO CONTRO LA CAMERA DEI DEPUTATI
Da oltre dieci anni sono vigenti in Italia disposizioni (Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e seguente regolamentazione tecnica) che impongono, fra l’altro, che le Pubbliche Amministrazioni forniscano informazioni in modo che siano accessibili e fruibili a tutti i Cittadini. La stessa Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, afferma e sottolinea il diritto all’accesso all’informazione. Secondo l’articolo 21 le persone con disabilità hanno diritto a ricevere informazioni su base di uguaglianza.
Quando ciò non accade la discriminazione è evidente. Nonostante ciò ancora oggi, che pur sono disponibili soluzioni tecnologiche diffuse e gratuite, molti siti istituzionali sono ancora inaccessibili alle persone non vedenti o ipovedenti e spesso sono scarsamente fruibili da chiunque. Un esempio evidente FISH* lo ha riscontrato nel sito della Camera dei Deputati.
Il testo del disegno di legge di stabilità, pubblicato nel sito ufficiale, non risponde ai più elementari requisti (condivisi a livello internazionale) di accessibilità. Ma di questo se ne accorge chiunque abbia tentato di consultare il testo a disposizione: esso è una scannerizzazione che impedisce una ricerca testuale, ad esempio, nelle tabelle di bilancio.
Ancora più grottesca l’inaccessibilità della VII Relazione sullo stato di applicazione della Legge 68 in materia di collocamento lavorativo delle persone con disabilità.
FISH ha quindi provveduto ad inviare un circostanziato esposto/segnalazione all’Agenzia Italia Digitale (AgID), organismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio, che svolge anche attività di controllo e che ha predisposto uno specifico percorso di segnalazione per queste situazioni (http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/accessibilita/segnalazione-siti-inaccessibili).
L’AgID, che certamente rileverà la fondatezza della segnalazione FISH, dovrà chiedere alla Camera l’adeguamento dei servizi erogati, assegnando un termine non superiore a 90 giorni per adempiere. Seguiremo l’evolversi del procedimento. In un’epoca di digitalizzazione spinta, di enfatizzazione della Pubblica Amministrazione digitale e di open data, le persone con disabilità non possono rimanere ancora una volta escluse e discriminate.
Le pagine e i documenti segnalati sono visibili ai seguenti link:
Disegno di legge di stabilità 2015
*FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, cui Anffas Onlus aderisce
LAVORO, STOP AI CONTRIBUTI PER CHI ASSUME LAVORATORI
Fonte www.superabile.it – Il fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, previsto dalla legge 68/99 sul collocamento obbligatorio, non sarà rifinanziato per l’anno 2015: dopo due anni consecutivi di incremento delle risorse, dunque, non ci saranno più soldi né per dare contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili a tempo indeterminato attraverso le convenzioni né per concedere i rimborsi parziali delle spese sostenute dalle aziende per l’adattamento del posto di lavoro.
E’ questo l’intendimento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso il quale la legge 68/99 aveva istituito il fondo e che ha il compito ogni anno di procedere al riparto delle somme fra le regioni. Il Fondo, partito con oltre 51 milioni di euro nel 1999-2000, aveva potuto contare fra il 2001 e il 2006 su una cifra annua di poco inferiore ai 31 milioni di euro, diventati poi 37 milioni nel 2007 e 42 milioni annui fra il 2008 e il 2010. Del 2011 la scelta di ridimensionarlo fin quasi all’azzeramento, con un taglio netto superiore al 90%: la dotazione per quell’anno fu di appena 2 milioni 725 mila euro, ulteriormente scesi nel 2012 a 2 milioni 430 mila euro. Primo segnale di ripresa nel 2013, con una dotazione di 12 milioni 590 mila euro, diventati poi 21 milioni 845 mila euro per il 2014.
Era stato il governo Letta a volere quest’ultimo incremento, anche in considerazione della decisione della Corte di Giustizia europea che nel luglio 2013 richiamò ufficialmente l’Italia per l’inadempienza del nostro paese nel garantire ai lavoratori con disabilità parità di trattamento. La Corte, con sede a Lussemburgo, affermava in quella circostanza che “l’Italia non ha ancora messo in atto misure efficaci ed appropriate per un effettivo inserimento professionale delle persone con disabilità” e chiedeva di porre rimedio quanto prima a questa inadempienza. Nei primi mesi del 2014, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva provveduto al riparto delle annualità 2013 e 2014 del Fondo, che ancora risultavano giacenti: le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2013 sono state ripartite con il decreto 530 del 21 febbraio 2014 (per un totale appunto di 12.590.387 euro), e quelle relative all’esercizio 2014 con il decreto 155 del 12 maggio 2014 (per 21.845.924 euro). Soldi che, come da normativa, sono andati a soddisfare le richieste relative alle assunzioni a tempo indeterminato stipulate nei 12 mesi precedenti alla data di emanazione dei rispettivi decreti di riparto.
In particolare, gli oltre 21 milioni di euro del Fondo 2014 – l’ultimo disponibile – sono andati a coprire 1.464 assunzioni avvenute nel periodo compreso fra l’11 maggio 2013 e l’11 maggio 2014.
Se l’intenzione di non rifinanziare il Fondo per il 2015 sarà confermata, rimarranno senza contributo non solo quei datori di lavoro che assumeranno d’ora in poi, ma anche quelli che hanno già assunto dal 12 maggio 2014 scorso in avanti.
Per chi ha stipulato convenzioni in tal senso, è una gran brutta notizia: basti pensare che gli oltre 21 milioni dell’ultimo riparto hanno coperto una parte consistente del costo salariale annuo (pari a 28 milioni 679 mila euro) sostenuto per le 1.464 assunzioni di cui sopra (la quota maggiore, 13 milioni di euro su 21 complessivi, era andata a Lombardia, Veneto e Piemonte, le cui aziende avevano assunto da sole circa 850 disabili sui 1.464 totali). La decisione che si profila per il 2015 arriva in un momento particolarmente critico per il lavoro delle persone con disabilità: la Relazione al Parlamento sull’attuazione della legge 68/99, predisposta proprio dal ministero del Welfare, ha fotografato nel biennio 2012-13 una riduzione dei nuovi avviamenti (calati nel 2013 al minimo storico, poco più di 18 mila) a fronte di un numero di iscritti alle liste del collocamento obbligatorio che rimane molto alto (oltre 676 mila disabili) e ad un numero di posti scoperti rispetto alle quote di riserva che arriva fra pubblico e privato a superare quota 41 mila.
Istituito presso il ministero del Lavoro e Politiche sociali dall’art. 13, comma 4, della legge 68/99, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è stata una delle principali innovazioni introdotte da quella normativa e ha rappresentato finora un valido strumento di incentivazione a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili nell’ambito di convenzioni stipulate dalla stessa normativa. Fino al 2007, in verità, aveva finanziato le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e gli oneri derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per i disabili tirocinanti, oltre al rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per l’adattamento del posto di lavoro.
In seguito alla modifica attuata con la legge 247/07 è stato poi introdotto in favore dei datori di lavoro un contributo per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo indeterminato attraverso le convenzioni previste dalla legge 68/99; confermando l’agevolazione di tipo economico relativa al rimborso parziale delle spese sostenute per l’adattamento del posto di lavoro. Il contributo per i nuovi assunti può partire dal 25% del costo salariale del soggetto e arrivare per i lavoratori con disabilità più grave fino al 60% del costo salariale. Il tutto a condizione che l’assunzione sia avvenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il rapporto di lavoro sia ancora in essere. Le risorse del fondo nazionale vengono ripartite fra le regioni secondo i criteri individuati nel DM 27 ottobre 2011.