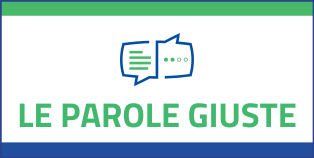28 marzo 2018. Anffas Open Day, porte aperte per celebrare 60 anni di futuro
Anche quest‘anno, come ormai abitudine, Anffas apre le sue porte all’interà collettività con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sui temi delle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo  promuovendo un messaggio di speranza affinché si affermino i principi e diritti civili e umani sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.
promuovendo un messaggio di speranza affinché si affermino i principi e diritti civili e umani sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.
La Giornata 2018 ha per Anffas un’importanza particolare: il 28 marzo 2018, infatti, Anffas compie 60 anni e quest’anno quindi, l’Open Day consentirà anche di ripercorrere la storia della nostra grande famiglia, una storia caratterizzata da grandi battaglie e grandi conquiste fatte per e con le persone con disabilità e loro famiglie, una storia che continua giorno dopo giorno con tante sfide e tanti traguardi ancora da raggiungere per il concreto e pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità.
L’Open Day 2018 darà così il via ufficiale alle celebrazioni del nostro sessantennale che si susseguiranno durante tutto il 2018: tutte le strutture Anffas Onlus distribuite sull’intero territorio nazionale, circa 1.000, organizzeranno molteplici iniziative – come seminari, proiezioni, convegni, spettacoli e tante altre manifestazioni volte a diffondere la cultura dell’inclusione sociale e della non discriminazione, attraverso la partecipazione attiva delle persone con disabilità, degli associati, degli operatori, dei volontari e di tutti coloro che operano in Anffas – e soprattutto porteranno all’attenzione delle varie comunità i tanti nuovi progetti, anche europei, che vedono le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo impegnate in prima persona, come i progetti sul linguaggio facile da leggere e sulla cittadinanza attiva e non mancheranno ovviamente i momenti dedicati appunto ai festeggiamenti dei 60 anni di Anffas che le Associazioni stanno già pianificando.
Come per gli anni passati la Giornata vuole diffondere una nuova cultura della disabilità, portando la collettività a contatto con una realtà che è molto distante da quella stereotipata che stigmatizza le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e che le vede, sbagliando, come persone passive e con limitazioni e solo abbisognevoli di assistenza, compassione e strutture e servizi sanitari, o, peggio, solo come pesi.
In occasione degli eventi legati al sessantennale sarà possibile ripercorrere la storia dei 60 anni di Anffas e, di pari passo, la storia di tutte le persone con disabilità italiane e delle loro famiglie. Avere un confronto e un contatto diretto con le comunità ed i territori in cui le nostre numerose associazioni operano in tutta Italia, e di conseguenza un coinvolgimento pieno dell’intera collettiva, consentirà di contrastare gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni che purtroppo ancora oggi circondano le persone con disabilità, in particolare con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, e rappresenterà un tassello in più nella costruzione di una società inclusiva che non discrimina nessuno e garantisce a tutti pari opportunità nel pieno rispetto dei nuovi paradigmi culturali introdotti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Nei prossimi giorni il programma della giornata.
ELEZIONI 4 MARZO 2018: ARRIVA DA ANFFAS IL KIT PER IL VOTO
PERCHÈ IL DIRITTO DI VOTO È DI TUTTI E PER TUTTI E LE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVE E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO SONO CITTADINI ED ELETTORI AL PARI DEGLI ALTRI
“Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:
… garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette…”: così inizia l’articolo 29 “Partecipazione alla vita politica e pubblica” della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, documento ratificato in Italia con la Legge n. 18/2009 e di conseguenza normativa vigente dello Stato Italiano da rispettare.
Ma questo avviene realmente?
“Purtroppo no” afferma Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale.
“In Italia manca una chiara normativa che garantisca alle persone con disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo i giusti sostegni nella presa di decisioni ed assistenza in cabina elettorale per esercitare il diritto/dovere di voto in condizioni di parità con tutti gli altri cittadini/elettori” continua il presidente “non solo viene, di fatto, inibito il diritto di voto ma le stesse tematiche legate alla disabilità non vedono dichiarati impegni concreti da parte delle varie forze politiche impegnate nella competizione elettorale. Tali aspetti e le relative proposte sono state evidenziate oltre che da Anffas stessa anche da Fish (Federazione Italiana Superamento Handicap) e dal Forum Nazionale del Terzo Settore a cui Anffas aderisce.
Inoltre Anffas ha realizzato in versione in linguaggio facile da leggere, un kit “guida alle elezioni” dedicato alle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, ai loro familiari e agli operatori. Nonostante nel nostro paese anche le persone sottoposte ad un regime di interdizione legale hanno diritto al voto, di fatto chi ha una disabilità intellettiva viene in maniera quasi automatica escluso da tale diritto. Infatti mentre sono previste alcune misure a sostegno dell’esercizio del diritto di voto per alcune persone in difficoltà (ad esempio le persone non vedenti, amputate degli arti, o con grave infermità) non vi è nessuna indicazione per le persone con disabilità intellettive per le quali, quindi, la legge non prevede alcuna modalità di supporto nell’esercizio del diritto di voto”.
“Eppure basterebbe davvero poco per dare questo sostegno, ad esempio fornire delle informazioni accessibili, quindi scritte in linguaggio facile da leggere, sia sui programmi politici che sulle modalità di voto, nonché garantire forme di supporto al voto anche in cabina”.
“Il voto dei cittadini con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo vale quanto quello di tutti gli altri cittadini e sono proprio loro a chiedere di poter esprimere le proprie opinioni e preferenze per partecipare realmente alla vita della comunità” prosegue Speziale “e visto che da parte delle istituzioni non sembra esserci alcuna intenzione di rispettare questo diritto, ci ha pensato Anffas, con una Guida al voto scritta in linguaggio facile da leggere (Easy To Read) che spiega agli elettori con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo quando si vota, per cosa si vota, come si vota e cosa è necessario fare una volta arrivati al seggio”.
“Abbiamo anche realizzato una guida per le famiglie e gli operatori per dare loro alcune indicazioni su come supportare al meglio le persone con disabilità intellettive che vogliono andare a votare e chiarendo alcuni punti come ad esempio il diritto al voto anche per le persone interdette o tutta la questione relativa all’accompagnamento in cabina elettorale”.
Su tali aspetti estremamente interessanti e puntuali sono gli approfondimenti redatti dalla Prof.ssa Lorenza Violini, Professore ordinario di diritto costituzionale dell’Università Statale di Milano, dal tiolo “Indicazioni alle famiglie in vista delle prossime scadenze elettorali”, e della Dott.ssa Giada Ragone, assegnista di ricerca in diritto costituzionale nell’università degli studi di Milano, dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, dal titolo “Prime note in materia di diritto di voto delle persone con disabilità intellettiva: dal riconoscimento della titolarità al sostegno nell’esercizio”.
“Queste Guide confermano l’impegno di Anffas per il rispetto dei diritti civili e politici delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, un impegno che si concretizza anche nel progetto (in corso di realizzazione) “Capacity: la legge è eguale per tutti”*, volto a sperimentare modelli innovativi di sostegno al processo decisionale per le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo in linea con quanto previsto dall’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità al fine di promuovere la loro piena inclusione sociale e la partecipazione alla cittadinanza attiva, che prevede un’analisi del sistema giuridico normativo italiano in relazione alla concreta attuazione dell’art. 12, anche a confronto con i sistemi introdotti a livello europeo ed internazionale, e una sperimentazione di modelli e pratiche innovativi di sostegno al processo decisionale attraverso la creazione di Toolkit (guide, tutorial, esercizi, risorse informatiche) rivolti a persone con disabilità, famiglie, operatori dei servizi, operatori dei sistemi di giustizia e del sociale.”.
“Quello che vogliamo” conclude il presidente di Anffas “è che la legge sia davvero eguale per tutti e che le parole e i diritti sanciti nell’art.48 della Costituzione Italiana e nell’art. 29 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità non rimangano sulla carta ma siano concretamente applicati”.
Il kit Anffas per le persone con disabilità, le famiglie e gli operatori è disponibile anche sul sito di Anffas Onlus a questo link
Appello Anffas Onlus in vista delle prossime elezioni politiche
Anffas Onlus è impegnata da 60 anni per la tutela e promozione dei diritti umani, l’inclusione sociale e la non discriminazione in particolare delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Promuovere e tutelare i diritti di persone a fortissimo rischio esclusione non può che significare battersi per la promozione dei diritti umani, il valore della diversità umana, la dignità di tutte le persone e, più in generale, per l’affermazione di modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili che mettano al centro le persone garantendo eguaglianza e pari opportunità a tutti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3, Costituzione Italiana).
Nell’approssimarsi del momento elettorale, le decine di migliaia di persone con disabilità, famiglie, volontari, amici, collaboratori che aderiscono alla rete Anffas in tutta Italia desiderano evidenziare preoccupazione ed allarme per il crescente clima di intolleranza, odio, violenza e discriminazione che sempre di più serpeggia nel nostro Paese, invadendo pericolosamente ognuna tra le aree fondamentali per la crescita sana e responsabile della Comunità: dalla scuola al lavoro, dalla salute alla vita sociale.
E’ per questo che la nostra Associazione, non intendendo porsi in schieramenti partitici, desidera dire inequivocabilmente NO alla violazione dei diritti, richiamando e ricordando i fondamentali valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della nostra Costituzione.
Anffas Onlus desidera dichiarare con forza:
NO ALL’ODIO E ALLA VIOLENZA!
NO AD OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE!
NO AI FASCISMI, AGLI ESTREMISMI, AGLI XENOFOBISMI, AI RAZZISMI, AI POPULISMI!
NO ALLE DISEGUAGLIANZE!
NO ALLE “LOTTE TRA POVERI”!
NO ALLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI CIASCUN
ESSERE UMANO!
E ribadire con altrettanta forza
SI AI DIRITTI UMANI DI TUTTI E DI TUTTE!
SI ALLA PARITA’ DI OPPORTUNITA’!
SI ALLA DIGNITA’ DI TUTTI GLI ESSERI UMANI!
SI ALLA DIVERSITA’ UMANA COME VALORE!
SI ALL’INCLUSIONE SOCIALE!
Tutto questo nella ferma convinzione che finché i diritti e la dignità di anche un solo essere umano saranno in pericolo, i diritti dell’intera umanità saranno in pericolo.
Il nostro è quindi un forte appello alle cittadine e ai cittadini tutti ed a tutte le forze politiche per un serio e concreto impegno affinché – come dichiarato negli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 che tutti i Paesi del mondo, incluso il nostro, sono impegnati a traguardare – nessuno sia escluso, né sia lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.
Si tratta quindi di un fermo invito affinché anche nell’esercizio del proprio diritto di voto, che mai come in questo momento è importante esprimere, in vista delle prossime elezioni politiche, i cittadini e le cittadine possano, con responsabilità e in piena libertà, tenere in forte considerazione questi che sono i punti cardine per una società libera ed equa.
Il Consiglio Direttivo Nazionale Anffas Onlus
ELEZIONI, IL FORUM TERZO SETTORE SCRIVE ALLE FORZE POLITICHE
Fonte comunicato stampa Forum Terzo Settore* – La piena realizzazione della Riforma del Terzo settore, un nuovo Piano di non autosufficienza in grado di tutelare concretamente chi è più vulnerabile, una politica dell’accoglienza capace realmente di inglobare i processi migratori nello sviluppo del Paese. Sono alcune delle priorità inserite all’interno della lettera aperta che il Forum Nazionale del Terzo settore ha indirizzato a tutte le forze politiche candidate alle elezioni del prossimo 4 marzo.
Nel documento, il Forum evidenzia gli aspetti fondamentali per costruire un modello di sviluppo sostenibile che ridia fiducia ai cittadini ed alle famiglie, che guardi alla tutela delle persone più fragili e che superi le gravi contraddizioni e le forti disuguaglianze ancora oggi presenti.
“Il modello al quale auspichiamo – dichiara la Portavoce del Forum Claudia Fiaschi – rimette al centro le sfide del benessere delle persone e del pianeta, della cultura della pace e della prosperità delle comunità, in Italia come nel mondo. Questo modello parte da una base condivisa: il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dalla comunità internazionale, che per noi rappresentano uno strumento semplice, ma universale, per rifondare un nuovo patto di cittadinanza capace di guardare al futuro, generare reddito e stabilire relazioni sociali.”
Il primo punto su cui il Forum intende richiamare l’attenzione è quello della riforma del Terzo settore.
“È necessario assicurarne la piena realizzazione– prosegue la Portavoce – considerando che tocca un mondo in continua espansione con 336.275 organizzazioni, oltre 5 milioni di volontari e quasi 800 mila dipendenti che ogni giorno lavorano per la costruzione di una società più inclusiva e sostenibile. La riforma rappresenta quindi un volano per lo sviluppo di un comparto che ha un ruolo fondamentale per il Paese.”
Altri punti sui quali il Forum richiede un impegno delle future forze politiche sono la riaffermazione della centralità di tutti i diritti; la garanzia di un welfare universalistico, in grado di promuovere e proteggere le persone anche quando diventano vulnerabili e fragili, attraverso un piano sulla non autosufficienza e sulla vita indipendente; la promozione della salute, del benessere e della qualità della vita per tutti, assicurando la cura della crescita del capitale umano per tutto l’arco della vita; la definizione di politiche di accoglienza capaci di inglobare i processi migratori all’interno dei più complessivi processi di sviluppo; la salvaguardia di natura, cultura e qualità degli ambienti di vita delle comunità umane; la ricerca di modelli di sviluppo economico inclusivi e sostenibili; l’aspirazione alla Pace e alla solidarietà internazionale.
“Le nostre proposte – conclude la Portavoce – pur non esaustive, rappresentano un punto di partenza per dotare il Paese di prospettive di crescita e dello slancio necessario al raggiungimento del progresso sociale. Diamo la nostra piena disponibilità ad un confronto con i candidati alle elezioni politiche con l’intento di concorrere alla costruzione di una nuova agenda per il Paese.”
Qui il documento “Valorizzare la partecipazione dei cittadini per il bene dell’Italia”
SCUOLA E DISABILI: I PREGIUDIZI PRESENTATI COME VALORI
Fonte comunicato stampa Fish* – È di ieri la pubblicazione di un articolo di denuncia de “la Repubblica” dal significativo titolo: “Qui niente poveri né disabili”: le pubblicità discriminatorie dei licei.
L’articolista (Corrado Zunino) ha effettuato una verifica su documenti pubblici e presenti nel portale istituzionale “Scuola in chiaro” del Ministero dell’Istruzione. In quel sito ogni istituto pubblica il proprio Rapporto di autovalutazione, cioè un documento pensato per orientare ragazzi e famiglie nella scelta della scuola.
Ebbene il pezzo, cui va il merito di aver portato all’evidenza gravi atteggiamenti discriminatori, riporta come troppi licei, di varie città, presentino come propri punti di forza, che favorirebbero “la coesione” e “l’apprendimento”, l’assenza tra gli alunni di ragazzi di origine straniera, poveri e con disabilità.
“Riteniamo gravissimo che proprio quei luoghi che dovrebbero rappresentare il luogo primario di promozione dell’inclusione e di rigetto della discriminazione siano invece i veicoli del pregiudizio e dello stigma. – stigmatizza Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap – Sono episodi che riportano indietro le lancette di decenni, che provocano repulsione non solo per l’ignoranza che non dovrebbe albergare nella scuola, ma anche l’insulto a milioni di persone con disabilità e loro familiari. Sì, molta strada è stata percorsa, ma di fronte a questi rigurgiti discriminatori comprendiamo che ce n’è ancora molta davanti a noi.”
La notizia ha provocato diffusa indignazione non solo nel movimento delle persone con disabilità, ma anche fra chi, all’interno del mondo scolastico, da anni si impegna per contrastare la discriminazione, per favorire l’inclusione di tutti considerando quello delle differenze un valore aggiunto e non un elemento da emarginare o escludere.
“Il retropensiero, subdolo e strisciante, che i bambini con disabilità siano un ostacolo è emerso in modo esplicito. E questo è gravissimo. Bene ha fatto il Ministro Fedeli – prosegue Falabella – a replicare immediatamente con una propria dichiarazione ufficiale di condanna e ad attivare un attento monitoraggio dei Rav in riferimento a questo tipo di episodi.”
*Cui Anffas Onlus aderisce
Parte anche in Calabria il Dopo Di Noi
Legge N. 112 del 2016 “ DOPO DI NOI “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Parte anche in Calabria il Dopo Di Noi, Legge n.112 del 2016, che mette a disposizione risorse a favore di persone con disabilità grave (Art. 3 comma 3 legge 104/92)che presentano i seguenti requisiti:
- la condizione di disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;-
- siano prive di sostegno familiare in quanto, alternativamente:
- mancanti di entrambi i genitori;
- con genitori non più in grado di fornire l’adeguato sostegno;
in vista del venir meno del sostegno familiare.In Calabria le risorse a disposizione ammontano a €4.362.200,00 relative agli anni 2016 e 2017. Tali somme sono state divise per ambiti territoriali. Il comune di Corigliano Calabro dispone di €108.106,58 Sul sito del comune è disponibile la documentazione necessaria per accedere al progetto DOPO DI NOI.
Gli interventi che Regione Calabria ha definito di finanziare con questo Fondo sono quelli di natura:
Interventi infrastruttuli
– Sostegno per ristrutturazione, miglioramento dell’accessibilità (eliminazione barriere), adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica ossia la gestione coordinata, integrata e computerizzata degli impianti tecnologici), per la messa a norma degli impianti,
– Sostegno spese di locazione/spese condominiali
Interventi gestionali
– Sostegno accompagnamento all’autonomia
-Sostegno residenzialità (Gruppo appartamento, soluzioni di Cohousing/Housing)
– Sostegno per pronto intervento.
– Interventi Infrastrutturali
Lo strumento per attivare il percorso della legge è la predisposizione del progetto individuale secondo art.14 della legge 328 del 2000. Il progetto deve essere costruito sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale e tenere in considerazione sia le abilità e capacità della persona, nonché le sue aspettative/motivazioni, in tutte le dimensione del vivere quotidiano. Tutto ciò in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dal nostro Stato nel 2009. La Convenzione Onu, infatti, impone di considerare le persone con disabilità non più per le loro limitazioni in sé (modello sanitario dell’ICDH) o non più solo per la relazione che si crea tra tali limitazioni e l’ambiente circostante (modello biopsico-sociale dell’ICF), ma per il loro essere PERSONE e, quindi, con il diritto intrinseco di avere, come ciascuna persona, un proprio percorso di vita, da poter sviluppare, in condizioni di pari opportunità con tutti gli altri, attraverso i giusti supporti e sostegni (modello dei diritti umani).
Anffas Onlus Corigliano
NUOVI LEA E NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO DEGLI AUSILI
Fonte www.superabile.it – Il 28 febbraio scade il termine ultimo per il secondo aggiornamento dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza). A fronte del mancato apporto delle modifiche richieste al dPCM, le Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità ribadiscono quanto sia inappropriato l’utilizzo della gara d’appalto, per la fornitura di ausili destinati a persone con disabilità gravissima.
Scooter, sedie a ruote elettriche, protesi acustiche, solo per fare alcuni esempi hanno spesso costi insostenibili per una persona o una famiglia media, soprattutto se consideriamo che gli stessi necessitano nell’arco della vita, di essere sostituiti a causa dell’usura dei materiali, per obsolescenza tecnologica, per mutamento delle condizioni psicofisiche del paziente.
Fondamentale dunque, che il Sistema Sanitario Nazionale si prefigga di coprire in misura importante, la spesa per la fornitura.
Facciamo il punto: la Legge di Stabilità dell’anno scorso ha vincolato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei Lea. Il centro di tutto è il decreto tariffe che recepisce le nuove prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, le valuta e stabilisce un prezzo. Del decreto e della tariffazione si sono occupati gli uffici preposti all’interno dei ministeri della Salute e dell’Economia.
Un ultimo, ma decisivo passo resta da compiere: fare approdare il tutto alla Conferenza Stato-Regioni. Tempi? Confidiamo che con la primavera sboccino anche i nuovi LEA. Il rischio è quello di nuocere, proprio a coloro che hanno assoluto bisogno di un intervento ed una valutazione personalizzata dei propri bisogni di cura. Le Asl si trovano infatti, nella situazione di poter fornire solo gli ausili presenti nel vecchio nomenclatore con le vecchie tariffe.