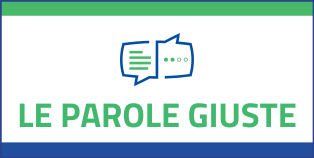LINK ISTITUZIONALI SUI MINORI, UN ELENCO ONLINE A CURA DEL GARANTE
Fonte www.infocontinuaterzosettore.it – Il Garante per i diritti dell’infanzia ha raccolto in una pagina web i link istituzionali contenenti dati sui minori, tra cui: minori stranieri non accompagnati, minori fuori famiglia in generale, minori autori di reato in carico ai servizi della giustizia minorile; informazioni, anche attraverso banche dati, in ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale dei minori.
Consulta la pagina cliccando qui
LAVORATORI CON DISABILITÀ: DA «OBBLIGO» A RISORSA
Fonte www.corriere.it/salute – I datori di lavoro li considerano «meno produttivi» e, per questo, li penalizzano pagandoli di meno rispetto ai colleghi che svolgono le stesse mansioni. Ci sono, poi, manager che si dichiarano propensi ad assumere un lavoratore con disabilità, ma di fatto non lo fanno.
La conferma che esistono ancora pregiudizi nelle strutture apicali delle aziende nei confronti di lavoratori con disabilità arriva da uno studio che ha messo a confronto indagini sull’inclusione lavorativa condotte a livello internazionale, presentato nel corso di un convegno “Disability management. Buone pratiche e prospettive future in Italia”, svoltosi di recente a Milano su iniziativa di “Best regards IBM Italia” e “Associazione pianeta persona”, e con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per leggere l’articolo integrale clicca qui
RIFUGIATI AL GELO IN EUROPA, LA DOPPIA DISCRIMINAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Fonte www.superabile.it – L’ondata di neve e gelo che ha colpito l’Europa negli ultimi giorni non accenna a diminuire. Tra le persone più in difficoltà ci sono i migranti bloccati ai confini d’Europa, a Belgrado come in Grecia, molti di loro vivono in condizioni al limite del disumano. In particolare, chi tra di loro ha una disabilità sta incontrando serie difficoltà nell’ottenere servizi di base come alloggio, servizi igienico-sanitari, ma anche cure mediche.
Lo denuncia l’organizzazione Human Rights Watch, in un focus sui centri di accoglienza in Grecia.
Tra i casi più eclatanti quello di un’anziana donna in sedia a rotelle, che non ha potuto farsi la doccia per un mese.
“Le persone con disabilità vengono trascurate e non riescono a ottenere servizi di base, anche se sono tra i rifugiati e gli immigrati più a rischio”, sottolinea Shantha Rau Barriga, direttore diritti delle persone con disabilità di Human Rights Watch. Human Rights Watch ricorda che sono ancora troppo pochi i programmi mirati a rispondere ai diritti e alle esigenze dei richiedenti asilo, rifugiati, e altri migranti con disabilità.
“L’accordo tra l’Unione Europea e la Turchia, le chiusure dei confini lungo la rotta dei Balcani, la cattiva gestione, e la mancanza di coordinamento tra i governi dell’Ue hanno lasciato circa 62.700 richiedenti asilo e altri migranti intrappolati in Grecia. Secondo la Commissione europea, a partire dal 12 gennaio 2017, solo 7448 persone sono state trasferiti o sono in programma di essere trasferite nell’ambito del meccanismo Ue Relocation – circa il 12 per cento dei 66.400 posti concordato nel 2015 – scrivono -. E i migranti in Grecia vivono in deplorevoli condizioni, senza accesso ai servizi e alloggi adeguati. Migliaia di rifugiati stanno sopportando condizioni invernali estremamente dure in tende fragili in tutta la Grecia, con temperature fino a -14 gradi. Quelli con disabilità sono tra quelli particolarmente a rischio”.
Sulla base delle ricerche svolte in Grecia continentale e sulle isole greche nel mese di ottobre 2016 e gennaio 2017, e di follow-up interviste telefoniche a dicembre 2016 e gennaio 2017, Human Rights Watch ha scoperto, inoltre, che i richiedenti asilo e i rifugiati con disabilità non sono spesso correttamente identificati, in parte a causa di un processo di registrazione affrettata. Senza un’adeguata comprensione delle dimensioni e esigenze, le agenzie umanitarie non possono rispondere in modo efficace.
Per esempio, i servizi di salute mentale, tanto necessari per i richiedenti asilo e gli altri migranti, sono inadeguati. La metà dei migranti che Human Rights Watch ha intervistato sta affrontando questa situazione portandosi dietro traumi, ansia o depressione dovuta alla violenza subita nei paesi d’origine, ma anche all’incertezza e l’insicurezza nei campi.
«QUESTA RIFORMA DEL SOSTEGNO È UNA PRESA IN GIRO»
Fonte www.vita.it – Riforma del sostegno e dell’inclusione scolastica, non ci siamo. Come denunciato proprio su Vita.it, erano molte le aspettative, in larghissima parte tradite: così la FISH- Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap* «rigetta all’unanimità» lo Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.
«Non si può certo dire che negli ultimi due anni la nostra Federazione non abbia praticato un confronto tecnico e politico con il Ministero dell’Istruzione. Lo abbiamo dimostrato ripetutamente in confronti diretti con la dirigenza politica e tecnica di quel Dicastero e siamo giunti persino ad elaborare e presentare anche una specifica proposta di legge, concordandone correzioni e aggiustamenti con il Ministero stesso», commenta Vincenzo Falabella, il presidente, alla conclusione della Giunta Nazionale della FISH convocata per confrontarsi sul testo della delega recentemente presentato dal Governo in Parlamento.
La proposta di Fish e Fand, sottoscritta da alcuni parlamentari e assegnata alla VII Commissione Cultura con il numero AC 2444 (qui il testo) puntava a favorire la continuità didattica, oggi frenata dal diffuso precariato, creando degli appositi ruoli per i docenti per il sostegno; ribadiva l’obbligo di riduzione del numero di alunni per classe e del numero di alunni con disabilità nella stessa classe e introduceva l’obbligo di formazione iniziale ed in servizio dei docenti sulle didattiche inclusive.
In questi mesi, dopo l’approvazione del testo della legge 107 sulla Buona Scuola, dalle dichiarazioni giunte dal Miur, sembrava che proprio a questa proposta di legge sarebbe stata sostanzialmente recepita dal Governo proprio come base della delega. Grandissima quindi la delusione nel vedere il testo dello schema di decreto: quella proposta era per Falabella «di ben altra qualità rispetto al papocchio che ora assume la veste di Atto del Governo. Ma quando l’Esecutivo ha assunto la delega in forza della legge sulla ‘buona scuola’, di quella apparente disponibilità al confronto si è persa la sostanza e il senso. Anzi, le istanze delle persone con disabilità sono state largamente ignorate se non contrastate.
Vediamo tradite le principali istanze del movimento delle persone con disabilità, mascherandole dietro dichiarazioni di intento ma declinandole in un nulla di davvero concreto, anzi tornando indietro rispetto anche alle minime garanzie attuali.
Temi come quelli della continuità scolastica, della garanzia di sostegno adeguato, della formazione dei docenti, della qualità scolastica, della corretta valutazione delle necessità e delle potenzialità degli alunni con disabilità, della programmazione sostenibile e congruente, della rivisitazione intelligente di ruoli, competenze, responsabilità sono – in tutta evidenza – tradite e, a tratti, irrise. In termini ancora più schietti: una presa in giro!».
A fronte a tali gravi considerazioni, visto ed analizzato il testo dello schema di decreto, il Presidente Vincenzo Falabella ribadisce che «la FISH e le associazioni federate non potranno che avviare una mobilitazione e tutte le forme di protesta e di denuncia utili a rivedere profondamente questo testo da cui prendiamo con vigore le distanze come associazioni e come cittadini».
*Cui Anffas Onlus aderisce
Il comunicato della Fish è disponibile cliccando qui
DELEGA SUL SOSTEGNO, IL NUOVO CHE SI ATTENDEVA NON C’È
Fonte www.vita.it – Sono oltre 224.000 gli studenti con disabilità iscritti alle scuole d’Italia. Le loro famiglie guardavano con grandissime aspettative alla delega collegata alla legge 107, che doveva non solo ridefinire le regole per la formazione degli insegnanti di sostegno e il loro accesso al ruolo, ma soprattutto ridisegnare il sistema dell’inclusione scolastica italiana, a quarant’anni dalla legge Falcucci.
«Nel testo che stiamo elaborando stiamo tenendo conto di tutte le criticità che sono emerse fin qui sul tema dell’inclusione degli studenti disabili, per eliminarle e per spazzare via una volta per tutte le ipocrisie che sporcano un sistema d’eccellenza a confronto con gli altri paesi europei. Per questo stiamo andando sempre più nella direzione di una maggiore formazione e competenza per i docenti di sostegno, che fanno un lavoro straordinario ma vanno preparati adeguatamente e in maniera più specializzata, ma anche e soprattutto di tutta la comunità scolastica, perché l’inclusione è responsabilità di tutti e non soltanto di un insegnante particolare per un certo numero di ore. Stiamo andando incontro alle esigenze delle famiglie dando continuità al sostegno per i propri figli, semplificando e uniformando a livello nazionale il sistema di certificazione. Stiamo guardando a un “progetto di vita” per questi ragazzi che tenga conto delle loro abilità e che vada oltre il piano educativo della scuola»: così ci diceva a settembre Davide Faraone, allora sottosegretario all’Istruzione.
Lo schema di decreto è stato approvato il 14 gennaio ed è stato trasmesso alla Camera (qui il testo) realizza quelle aspettative? Vita lo ha chiesto a tre esperti.
1. DARIO IANES «Una delega pensata per ridurre le ore di sostegno» Docente ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale all’Università di Bolzano, co-fondatore del Centro Studi Erickson di Trento. «C’è ben poco da dire, tutte le grandi attese sono deluse, soprattutto delle associazioni di famigliari», sbotta il professore: «non vedo nessuna evoluzione concettuale del sistema». Partiamo dalla continuità, tema cruciale per alunni e famiglie, che oggi vivono il caos assoluto: «il fatto che l’insegnante di sostegno prima di chiedere il passaggio sui posti comuni debba stare per dieci anni sul sostegno, non garantisce alcuna continuità didattica», spiega il professore, poiché anche stando sul sostegno l’insegnante potrebbe cambiare ogni anno scuola e alunno.
Quanto alla formazione degli insegnanti, con la richiesta di una formazione di base sui temi dell’inclusione per tutti gli insegnanti, compresi quelli della scuola secondaria, «non c’è nulla e questo è un grave problema. Noi nei mesi scorsi abbiamo denunciato le preoccupazioni rispetto all’ipotesi di separazione dei percorsi universitari, che non c’è; d’accordo, non c’è quella biforcazione dei percorsi che temevamo, però non è che io sia contento, perché anche le cose buone che c’erano nella proposta quadro di Fish e Fand, ad esempio sulla continuità, qui non ci sono».
Tornando alla formazione degli insegnanti, tanto ripetuta, per Ianes «c’è solo un corso di specializzazione sul sostegno, da 60 crediti, come oggi. I 120 crediti di cui parla il testo sono divisi in realtà in due, 60 al corso e 60 pregressi per poter accedere al corso. E cosa devo fare per maturare quei 60 crediti? Per la primaria ti puoi far riconoscer quelli fatti durante l’università, il tirocinio e la tesi, quindi di fatto la formazione è uguale ad oggi. Sulla secondaria invece, che in università ha solo 6 o 7 crediti sull’inclusione, non si capisce dove uno possa andare a prenderli. Forse facendo un anno di scienze della formazione, ma è folle: 5 anni per la laurea + 3 per la formazione secondaria per insegnare, più uno per accedere al corso di specializzazione più uno di corso: dieci anni di formazione? È ridicolo».
Ma il nodo più pericoloso per il professor Ianes si nasconde nell’articolo 8, quello che disegna il GIT, Gruppo per l’inclusione territoriale. «Ce ne saranno 300, uno per ambito, composti da docenti e dirigenti e saranno loro a quantificare la proposta di ore di sostegno. A quantificare il sostegno di cui l’alunno ha bisogno non sarà più dunque la realtà decisionale più vicina alla scuola, al ragazzo, alla famiglia, c’è questo “allontanamento” che sarà un meccanismo di freno, è scritto nella relazione. Dopo aver avuto le ore, la scuola fa il PEI, partendo dalle risorse assegnate. Il PEI non è più la fonte delle risorse, c’è uno scollamento. A pensar male, si può dire che tutta delega sia fatta per questo, per ridurre le ore di sostegno. La sola parte dove si modificano i meccanismi è questa e non mi piace perché sono meccanismi che frenano la spesa, il resto sono proclami».
2. SALVATORE NOCERA «Nessuna possibilità concreta di presa in carico da parte dei docenti curricolari» Avvocato, esperto tecnico della Fish in campo di inclusione scolastica «Ho letto la relazione, il testo ancora no perché purtroppo non è accessibile ai non vedenti. Il mio giudizio è prevalentemente positivo, il testo accoglie molte delle nostre richieste, anche se ne lascia indietro altre», afferma Nocera, precisando di parlare «a titolo personale». Positivo è il passaggio al profilo di funzionamento, che rimanda alla disabilità come una situazione dinamica, collocata nel contesto. Positivo è anche il collegamento fra scuole ed enti locali, perché non deve essere solo la scuola ad occuparsi degli alunni con disabilità, come pure il riferimento al PEI come parte integrante del progetto individuale previsto dalla legge 328 e soprattutto il chiarimento sull’istruzione a domicilio in analogia con l’istruzione in ospedale. Cinque invece per Nocera sono i punti dolenti: «Primo, non viene messa in luce l’importanza della famiglia nella formulazione del PEI, la 328 prevede che la famiglia partecipi, qui invece questo non è previsto. È un passo indietro inaccettabile».
Secondo punto si abroga il GLIP provinciale per il GIT, però nel GLIP erano presenti le associazioni e gli enti locali, nel GIT ci sono solo componenti interni all’amministrazione scolastica, questo non va bene».
Terzo, il numero massimo di alunni per classe, nelle classi iniziali di ogni ciclo, qualora vi sia un alunno con disabilità: «è una manovra quasi truffaldina, si dice al massimo 22, ma la regola diceva invece già dal 2009 al massimo 20 di norma, tranne casi eccezionali». L’avvocato cita articoli e commi, il succo è che «di fatto si lascia la libertà di creare classi-pollaio. Qua si va indietro, decisamente».
Venendo alla presa in carico da parte di tutti i docenti curricolari, «non c’è nessuna novità sulla formazione che disegni la possibilità concreta che i curricolari si occupino di inclusione: tutta la novità che si pensava non c’è. Per chi insegnerà alla scuola secondaria sei crediti erano e sei restano, noi ne chiedevamo 30». E pure per la carriera degli insegnanti di sostegno «non abbiamo la classe di concorso separata, si prevedono 4 ruoli di sostegno ma sempre con la possibilità di passare a cattedre comuni dopo 10 anni, sì, c’è la possibilità di avere una supplenza per un anno in più, ma noi chiedevamo almeno una continuità di almeno due anni o dell’intero ciclo. Questo è un punto nodale e non c’è una riga». Infine, guardando al decreto sulla valutazione degli alunni, c’è un «arretramento pauroso», arrivato del tutto a sorpresa, là dove si dice che alla fine della scuola secondaria di primo grado gli alunni «devono fare prove d’esame equipollenti, dimostrando di conoscere elementi basilari della disciplina e non prove differenti, come previsto dalla legge 104. Moltissimi ragazzi non avranno il diploma ma solo un attestato, andranno alla scuola superiore ma anche lì non potranno fare l’esame maturità, potranno avere solo un attestato. È un punto che non condividiamo assolutamente».
Dal punto di vista politico, già lunedì pomeriggio il presidente della Fish, Vincenzo Falabella, aveva esternato la sua «amarezza» per un testo «assolutamente non condiviso, che non ha fato nemmeno un passaggio in Osservatorio, in palese violazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e del nulla su di noi senza di noi. La stessa cosa è stata fatta con i Lea. Credo ci sia la volontà deliberata di tener fuori dal confronto politico le persone con disabilità» (Clicca qui per leggere il comunicato)
3. EVELINA CHIOCCA «La famiglia, la grande esclusa» presidente del CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno) Testi alla mano, la professoressa esamina articolo per articolo il testo della legge. «La prima osservazione che voglio fare però è complessiva: vedo poco la presenza della famiglia, che dovrebbe invece essere più partecipe», afferma. Positivo per lei è l’articolo che prevede una valutazione della qualità dell’inclusione, «è un primo passaggio, segno di un cambiamento di cultura». Bene anche l’introduzione della valutazione diagnostico-funzionale, a sostituire i due documenti precedenti: «la cosa importante è l’esplicito riferimento all’approccio ICF, che ci dice non l’elenco di ciò che manca all’alunno ma quello di ciò che l’alunno possiede, tenendo conto di tutti gli aspetti di vita del ragazzo. È un’ottica pedagogica importante».
Perfetto anche a livello di principio il quantificare le risorse non in base a un codice standard ma in base agli effettivi bisogni di ciascuno. Il problema è che «le risorse non discenderanno dal PEI ma saranno quantificate e decise dal GIT, un soggetto dove non ci sono né famiglie né associazioni. Intanto noto che le risorse non sono più scritte nel PEI, quindi non ci sarà più possibilità di fare ricorso per le famiglie per chiedere più ore di sostegno. In secondo luogo il PEI viene elaborato dai docenti insieme ai genitori, ma approvato solo dai docenti, ma la famiglia non può essere esclusa in questo modo».
La professoressa si dice «disorientata» anche dal passaggio sul corso di specializzazione: dove si fanno i 60 crediti necessari per accedervi? Durante l’università? Con un anno in più di università? Per la secondaria in particolare non si capisce proprio come si possa fare. «Delusione» quindi, anche sul fronte della formazione iniziale obbligatoria per tutti gli insegnanti curricolari, su cui «non vedo novità».
Per approfondire leggi il comunicato Fish cliccando qui
DECRETO SU INCLUSIONE SCOLASTICA DA RIGETTARE
Fonte comunicato stampa Fish* – Unanimità della Giunta FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap nel rigettare con forza lo “Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, l’Atto del Governo (378) approdato all’esame delle Camere in questi giorni.
“Non si può certo dire che negli ultimi due anni la nostra Federazione non abbia praticato un confronto tecnico e politico con il Ministero dell’Istruzione. Lo abbiamo dimostrato ripetutamente in confronti diretti con la dirigenza politica e tecnica di quel Dicastero. Siamo giunti persino ad elaborare e a presentare anche una specifica proposta di legge concordandone correzioni e aggiustamenti con il Ministero stesso di ben altra qualità rispetto al papocchio che ora assume la veste di Atto del Governo. Ma quando l’Esecutivo ha assunto la delega in forza della legge sulla ‘buona scuola’, di quella apparente disponibilità al confronto si è persa la sostanza e il senso. Anzi, le istanze delle persone con disabilità sono state largamente ignorate se non contrastate.” Così commenta Vincenzo Falabella alla conclusione della Giunta Nazionale della FISH convocata per confrontarsi su questo aspetto e per stabilire la posizione da tenere.
“Vediamo tradite le principali istanze del movimento delle persone con disabilità, mascherandole dietro dichiarazioni di intento ma declinandole in un nulla di davvero concreto, anzi tornando indietro rispetto anche alle minime garanzie attuali. Temi come quelli della continuità scolastica, della garanzia di sostegno adeguato, della formazione dei docenti, della qualità scolastica, della corretta valutazione delle necessità e delle potenzialità degli alunni con disabilità, della programmazione sostenibile e congruente, della rivisitazione intelligente di ruoli, competenze, responsabilità sono – in tutta evidenza – tradite e, a tratti, irrise. In termini ancora più schietti: una presa in giro!”
E di fronte a tali gravi considerazioni, visto ed analizzato il testo dello schema di decreto, il Presidente Vincenzo Falabella ribadisce che “la FISH e le associazioni federate non potranno che avviare una mobilitazione e tutte le forme di protesta e di denuncia utili a rivedere profondamente questo testo da cui prendiamo con vigore le distanze come associazioni e come Cittadini.”
* Cui Anffas Onlus aderisce
PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI
Fonte www.handylex.org – Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2017 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare 17 gennaio 2017, n. 8.
Il sito HandyLex riporta in un tabella gli attuali importi in euro, comparati con quelli del 2016. La tabella è disponibile a questo link