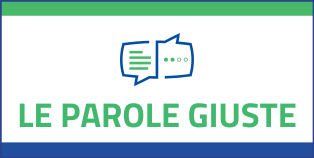GINEVRA. DIALOGO MANCATO SULLA CONVENZIONE ONU
Superando.it – L’Italia sotto la lente dell’ONU, aveva titolato un articolo Superando.it la scorsa settimana, presentando il cosiddetto “Dialogo Costruttivo” di Ginevra, durante il quale il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità – organismo che verifica lo stato di applicazione della Convenzione nei vari Paesi che l’hanno ratificata – avrebbe dovuto ascoltare le risposte italiane ai numerosi quesiti posti dal Comitato stesso.
ISEE PERSONE CON DISABILITÀ. IL RICALCOLO D’UFFICIO È A CURA DELL’INPS
Disabili.com – Come ormai noto, sulle modalità di calcolo dell’ISEE si è giunti alla decisione di eliminare da essa il conteggio di pensioni, assegni, indennità riservate alle persone con disabilità e aumentando le scale di equivalenza, togleindo invece le franchigie in base alla gravità e l’età.
RIO 2016, DUE GLI AZZURRI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA ALLE PARALIMPIADI
Superabile.it – Due atleti FISDIR a caccia di medaglie. Xenia Francesca Palazzo e Ruud Lorain Flovany Koutiki Tsilulu: questi i nomi dei due rappresentanti della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale che, dal 7 al 18 settembre, difenderanno i nostri colori in occasione dei XV Giochi Paralimpici di Rio 2016.
La Palazzo, classe 1998, nata a Palermo ma residente a Verona, farà parte dello squadrone di nuoto che, in Brasile, proverà a scrivere una pagina indelebile nella storia non solo di questa disciplina ma, più in generale, dell’intero movimento degli sport disabili. Le premesse sono ottime, le aspirazioni di medaglia numerose, il valore dei nostri atleti elevatissimo.
Esordiente ai Giochi, l’azzurra vanta, nel suo palmares, ben 6 ori agli Europei del 2014 a Liberec, in Repibblica Ceca. “Partecipare alle Paralimpiadi significa raggiungere l’obiettivo più grande e desiderato di ogni atleta – ammette la portacolori del Team Sport Isola – il sogno di prender parte a questo evento, che coltivavo sin da piccola, è diventato realtà”. “Faccio parte di una squadra molto forte, fatta di amici – spiega l’azzurra – un gruppo che lotta per dimostrare tutto il suo potere e valore”. “Per Rio mi sto allenando quattro ore al giorno – aggiunge la Palazzo – in gara non temo nessuno, gli avversari sono forti ma io scendo in vasca per nuotare e basta, cercando di battere i miei tempi”. “Sono orgogliosa di vestire la maglia della Nazionale – prosegue la Palazzo – e di difendere i colori dell’Italia”. “Ai Giochi punto a qualificarmi per le finali – conclude la nuotatrice – è questo, da sempre, il mio obiettivo”.
E’ nato nel 1989 a Brazzaville, in Congo. Risiede ad Ascoli Piceno ed è tesserato per la AS Culturale Anthropos Civitanova. In Brasile farà parte della Squadra di atletica leggera, specialità 400 metri. Anche per Ruud, come per Xenia, Rio rappresenta l’esordio ai Giochi: “Partecipare a una Paralimpiade è un’opportunità che non capita a tutti gli atleti – esordisce Koutiki – ringrazio la Federazione, la Nazionale, il mio Presidente e i miei tecnici per avermi dato la possibilità di essere a Rio”.
“L’avversario che devo temere maggiormente sono proprio io – confessa Koutiki, oro continentale a Swansea nel 2014 – perché so che devo impegnarmi al massimo se voglio raggiungere obiettivi importanti”. “L’atletica per me è vita, mi piace, mi stimola – sostiene Ruud – significa correre con te stesso e mostrare alle persone quanto vali”. “Vestire la maglia della Nazionale è un privilegio per me – conclude Koutiki – perché l’Italia è un Paese che mi ha dato l’opportunità di essere quello che sono oggi”.
ALUNNI CON DISABILITÀ E BISOGNI SPECIALI, DAL MIUR 2 MILIONI PER L’INTEGRAZIONE
Superabile.it – Due milioni di euro per l’integrazione degli studenti disabili e con bisogni educativi speciali; 6,7 milioni di euro per il potenziamento dello sport a scuola; piu’ di 6 milioni per mettere in campo progetti fra educazione alimentare, alla legalita’, educazione stradale e contrasto a bullismo e cyber-bullismo. Il ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato il decreto che finanzia l’ampliamento dell’offerta formativa e l’autonomia scolastica (ex legge 440) per l’anno scolastico 2016/2017. Sono 80 i milioni a disposizione delle scuole, che si sommano ai 10 milioni gia’ stanziati con il progetto ‘La Scuola al Centro’ per finanziare i programmi di apertura estiva degli istituti di quattro città: Milano, Roma, Napoli, Palermo.
“Oltre il 60% delle risorse e’ destinato a misure che riguardano gli studenti. Quest’anno abbiamo piu’ che triplicato le risorse per lo sport – sottolinea il ministro Giannini- passando dai 2 milioni del 2015 a 6,7. Continuiamo ad investire sull’integrazione dei ragazzi con cittadinanza non italiana, dando una specifica attenzione anche ai minori che arrivano nel nostro Paese non accompagnati, un tema di stringente attualità Fra le voci nuove che abbiamo voluto inserire, i finanziamenti per potenziare i progetti lanciati lo scorso anno per l’introduzione a scuola del Public Debate e del Public Speaking affinche’ i ragazzi possano imparare ad argomentare le loro idee, a farle capire e valorizzarle”.
Fra le misure destinate ai ragazzi, 2,5 milioni vanno a scuola in ospedale e istruzione domiciliare; 1 milione servira’ a realizzare progetti di accoglienza, di sostegno linguistico e psicologico rivolti a minori non accompagnati con cittadinanza non italiana e ad alunni stranieri. Quasi 2 milioni (di cui 700.000 euro destinati alle Consulte) finanzieranno la partecipazione studentesca. Public Debate e Public Speaking arrivano nel sistema scolastico: quasi 2 i milioni a disposizione che serviranno, fra l’altro, anche per organizzare le prime Olimpiadi di Public Debate nazionali; 350.000 euro vanno al Piano educazione stradale, 1,5 milioni per promuovere corretti stili di vita, 2,4 milioni per i progetti di educazione alla legalita’ e cittadinanza attiva. Mentre 2 milioni finanziano il contrasto del bullismo e del cyber-bullismo; 2,3 milioni saranno destinati alla realizzazione di un Piano di Interventi nazionale per l’orientamento scolastico; 1,5 milioni per la scuola in carcere; 3,5 milioni per il welfare dello studente e per il diritto allo Studio. Per i corsi di recupero ci sono 6,8 milioni. Mentre 5 milioni finanziano “Progetti di innovazione sociale” di contrasto alla dispersione che vedranno i ragazzi coinvolti nell’elaborazione di risposte innovative per la valorizzazione del patrimonio artistico del loro territorio, dell’ambiente, del paesaggio, della tradizione locale.
Prosegue l’attenzione per la sicurezza degli istituti e l’efficienza dell’edilizia scolastica, con oltre 6 milioni di euro da destinare alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole (100.000 euro), alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per la didattica digitale (2,7 milioni), all’ulteriore finanziamento di biblioteche innovative (2,5 milioni), al progetto “Scuole accoglienti” che prevede il recupero di spazi inutilizzati nelle scuole per realizzare laboratori creativi (1 milione). Per l’alternanza scuola lavoro, gia’ finanziata con i 100 milioni all’anno previsti dalla Buona Scuola, vengono destinati 1,6 milioni fra finanziamento dell’apprendistato di primo livello e promozione delle migliori pratiche. Quasi 2 milioni vanno alla formazione degli adulti. 1,5 milioni allo sviluppo della metodologia Clil.
Sul fronte del personale della scuola, il decreto stanzia 1 milione per sviluppare le competenze dei dirigenti scolastici sulle innovazioni introdotte dalla legge 107, con particolare riferimento all’organico di potenziamento e alla crescita professionale continua del personale della scuola; 2,3 milioni andranno alla formazione del personale ATA. Quasi 5 milioni finanziano lo sviluppo del sistema di valutazione. La valorizzazione della figura del docente passa anche attraverso l’assegnazione del Premio Nazionale Insegnanti, l’Italian Teacher Prize, che verra’ attribuito per la prima volta quest’anno, in accordo con il Global Teacher Prize, che viene finanziato con la somma di 200.000 euro.
UNICEF PER L’INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA
Inclusion-international.org – Inclusion International accoglie il Rapporto annuale 2015 dell’UNICEF e, in particolare, le sue raccomandazioni in favore dei bambini con disabilità.
Ai bambini con disabilità è spesso negato il loro diritto all’istruzione e pertanto gli sforzi dell’Unicef nel 2015 sono stati rivolti a promuovere l’inclusione scolastica a favore di questi soggetti svantaggiati.
Inoltre l’Annual Report riflette la necessità di orientare/indirizzare le norme sociali dannose e favorire l’inclusione dei bambini più emarginati.
L’inclusione sociale e quella scolastica sono due chiavi importanti per abbattere le barriere e garantire che ai bambini con disabilità intellettiva sia data l’opportunità di vivere una vita serena, imparare e crescere insieme ai loro coetanei.
L’UNICEF ha la credibilità e la capacità di aiutare i governi e gli altri soggetti per far si che questo possa divertare una realtà per i bambini con disabilità intellettiva e le loro famiglie. Inclusion International è onorata di lavorare al fianco di UNICEF su questo fronte e di collaborare con tutti i partner per garantire che nessuno sia lasciato indietro.
Per leggere l’Annual Report 2015 di UNICEF cliccare qui
ORLANDO. SHAPING THE FUTURE 2016
Inclusion-international.org – A Orlando il 27-28-29 ottobre prossimi si svolgerà “Shaping the Future”, forum internazionale e convegno nazionale sull’inclusione delle persone con disabilità e le loro famiglie, organizzato da Inclusion International in collaborazione con l’organizzazione Arc of the United States.
Verranno affrontati alcuni temi caldi e questioni importanti per le persone con disabilità intellettiva e le loro famiglie tra i quali: l’inclusione scolastica e quella sociale, l’occupazione, l’accesso effettivo alla giustizia, la partecipazione politica, lo sviluppo inclusivo, le leggi sulla morte assistita eccetera.
FIRENZE, A SETTEMBRE LA V CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLA DISABILITÀ
Lavoro.gov.it – Si svolgerà a Firenze alla Fortezza da Basso, il 16 e 17 settembre, la V Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità.